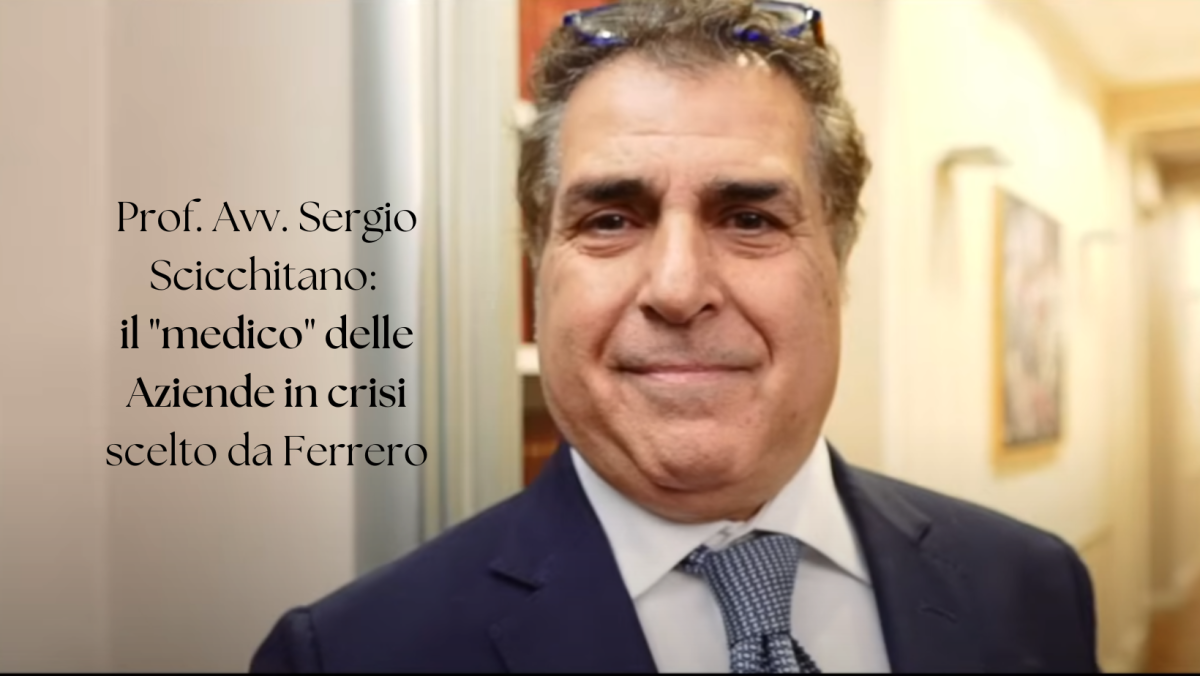Cassazione 34809/2025: nella bancarotta fraudolenta non serve il nesso causale con il fallimento
Con la sentenza n. 34809/2025, emessa in data 26.09.2025 e pubblicata in data 24.10.2025, la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato una questione giuridica di notevole rilevanza.
Gli Ermellini hanno, infatti, chiarito come non sia assolutamente necessario, ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sussistenza di un eventuale nesso causale tra i fatti distrazione e la successiva dichiarazione di fallimento dell’impresa.
In questa ricostruzione, risulterebbe sufficiente che
“l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività” a tal punto che “una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza”.
La fattispecie incriminatrice richiamata, allora, configura un reato di pericolo concreto e la dichiarazione di fallimento, pur costituendo una “condizione oggettiva di punibilità”, rientrerebbe tra quegli accadimenti ulteriori che andrebbero ad aggiungersi ad una condotta di per sé già offensiva, limitandosi a renderla attuale ovvero ad aggravarne la portata.
Così opinando, la Corte si è posta in linea con la precedente Giurisprudenza di legittimità, richiamandovisi esplicitamente.
A tenore delle S.U. Passerelli, invero, la dichiarazione di fallimento costituirebbe bensì una condizione obiettiva di punibilità ma, in alcun modo, una tale affermazione verrebbe a porsi in contrasto con la riconosciuta natura di reato a pericolo concreto della bancarotta fraudolenta.
Anzi, a sostegno di questa tesi, militano altresì Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, nonché Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Signoretti.
Questa impostazione ha conseguenze precise sull’individuazione del tempus commissi delicti.
La condotta criminosa va, dunque, ritenuta commessa al momento della dichiarazione di fallimento, atteso che prima di questa data l’imputato avrebbe potuto porre in essere un’attività di segno contrario rispetto a quella illecita compiuta, così annullando gli effetti pregiudizievoli ai creditori delle proprie distrazioni patrimoniali.
Se tale re-integrazione non avviene (come, invece, accade nella bancarotta cd. “riparata” che “si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno – Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261347”), ne consegue che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale si considera commesso al momento della dichiarazione di fallimento.
È solo infatti con quest’ultima che il pericolo di danno ai creditori assume carattere di concretezza e, pertanto, si ritengono pienamente integrati gli estremi dell’illecito penale in discorso.
Nel caso di specie, quindi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato che, con un secondo motivo, aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello di Trieste nella parte in cui quest’ultima aveva revocato la sospensione condizionale della pena in precedenza concessa, sulla base di un reato che, secondo la difesa costituita, sarebbe stato da intendersi tecnicamente consumato prima del passaggio in giudicato della sentenza (2016) che aveva accordato il beneficio; mentre il Giudice di Seconde Cure avrebbe erroneamente ritenuto l’elemento materiale del reato perfezionatosi al tempo della dichiarazione di fallimento (2017), quindi in data posteriore alla sospensione condizionale concessa.
Ad avviso della Suprema Corte, pertanto, il tempus di commissione va individuato nella dichiarazione di fallimento, che costituisce elemento costitutivo del reato in oggetto: con la conseguenza che, essendo stato commesso nell’arco di appena un anno successivo alla sentenza che aveva sospeso la pena un ulteriore delitto della medesima indole, va constatata la decadenza ipso iure dell’imputato dal beneficio ricevuto.
Dott. Gennaro Ferrante
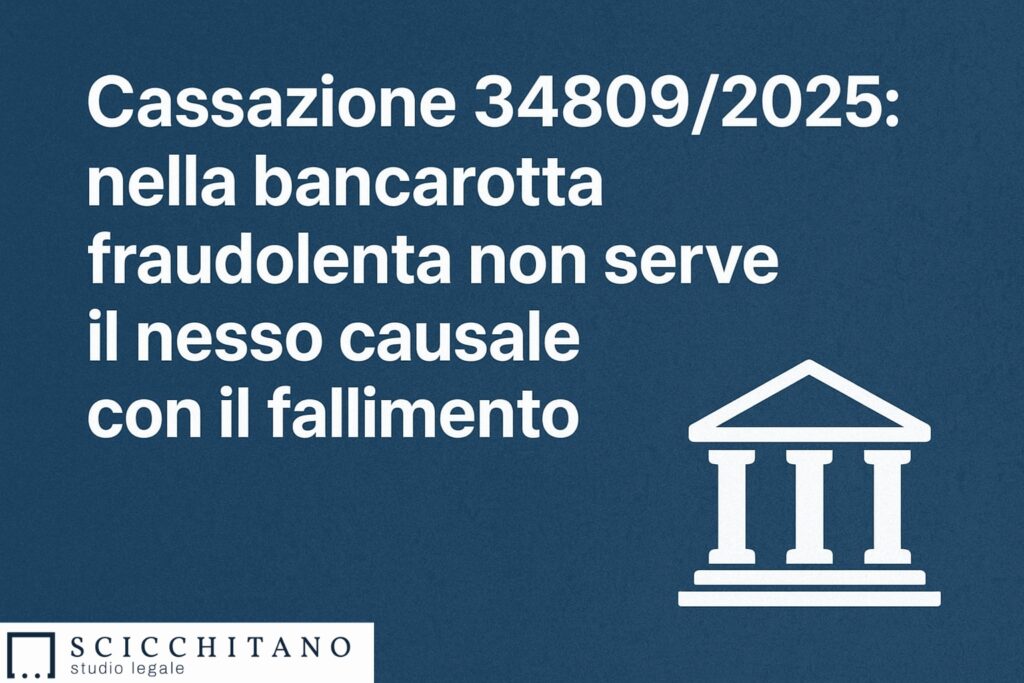

Cassazione 34809/2025: nella bancarotta fraudolenta non serve il nesso causale con il fallimento
Con la sentenza n. 34809/2025, emessa in data 26.09.2025 e pubblicata in data 24.10.2025, la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato una questione giuridica di notevole rilevanza.
Gli Ermellini hanno, infatti, chiarito come non sia assolutamente necessario, ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sussistenza di un eventuale nesso causale tra i fatti distrazione e la successiva dichiarazione di fallimento dell’impresa.
In questa ricostruzione, risulterebbe sufficiente che
“l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività” a tal punto che “una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza”.
La fattispecie incriminatrice richiamata, allora, configura un reato di pericolo concreto e la dichiarazione di fallimento, pur costituendo una “condizione oggettiva di punibilità”, rientrerebbe tra quegli accadimenti ulteriori che andrebbero ad aggiungersi ad una condotta di per sé già offensiva, limitandosi a renderla attuale ovvero ad aggravarne la portata.
Così opinando, la Corte si è posta in linea con la precedente Giurisprudenza di legittimità, richiamandovisi esplicitamente.
A tenore delle S.U. Passerelli, invero, la dichiarazione di fallimento costituirebbe bensì una condizione obiettiva di punibilità ma, in alcun modo, una tale affermazione verrebbe a porsi in contrasto con la riconosciuta natura di reato a pericolo concreto della bancarotta fraudolenta.
Anzi, a sostegno di questa tesi, militano altresì Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, nonché Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Signoretti.
Questa impostazione ha conseguenze precise sull’individuazione del tempus commissi delicti.
La condotta criminosa va, dunque, ritenuta commessa al momento della dichiarazione di fallimento, atteso che prima di questa data l’imputato avrebbe potuto porre in essere un’attività di segno contrario rispetto a quella illecita compiuta, così annullando gli effetti pregiudizievoli ai creditori delle proprie distrazioni patrimoniali.
Se tale re-integrazione non avviene (come, invece, accade nella bancarotta cd. “riparata” che “si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno – Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261347”), ne consegue che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale si considera commesso al momento della dichiarazione di fallimento.
È solo infatti con quest’ultima che il pericolo di danno ai creditori assume carattere di concretezza e, pertanto, si ritengono pienamente integrati gli estremi dell’illecito penale in discorso.
Nel caso di specie, quindi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato che, con un secondo motivo, aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello di Trieste nella parte in cui quest’ultima aveva revocato la sospensione condizionale della pena in precedenza concessa, sulla base di un reato che, secondo la difesa costituita, sarebbe stato da intendersi tecnicamente consumato prima del passaggio in giudicato della sentenza (2016) che aveva accordato il beneficio; mentre il Giudice di Seconde Cure avrebbe erroneamente ritenuto l’elemento materiale del reato perfezionatosi al tempo della dichiarazione di fallimento (2017), quindi in data posteriore alla sospensione condizionale concessa.
Ad avviso della Suprema Corte, pertanto, il tempus di commissione va individuato nella dichiarazione di fallimento, che costituisce elemento costitutivo del reato in oggetto: con la conseguenza che, essendo stato commesso nell’arco di appena un anno successivo alla sentenza che aveva sospeso la pena un ulteriore delitto della medesima indole, va constatata la decadenza ipso iure dell’imputato dal beneficio ricevuto.
Dott. Gennaro Ferrante
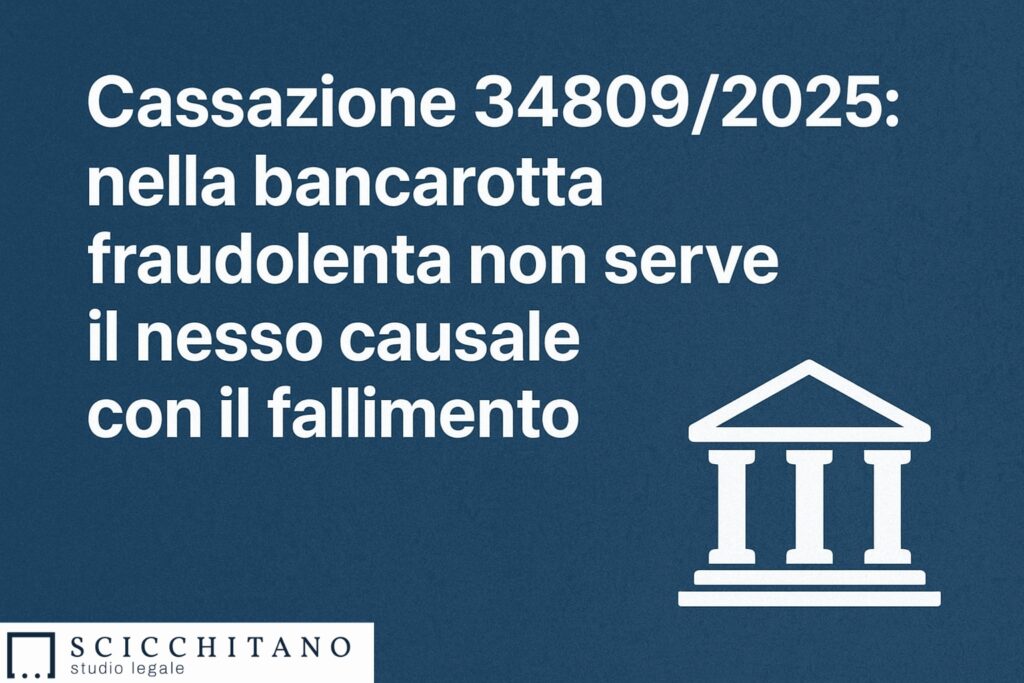
Recent posts.
Gestione della crisi Eleven Finance: il piano dell'Avv. Sergio Scicchitano "Ho scelto il migliore". Titola così il documento allegato qui di seguito, che illustra il piano di ristrutturazione predisposto per Eleven Finance srl, società [...]
Con la sentenza n. 34809/2025, emessa in data 26.09.2025 e pubblicata in data 24.10.2025, la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato una questione giuridica di notevole rilevanza. Gli Ermellini hanno, infatti, [...]
Nel panorama giuridico italiano, raramente una questione apparentemente tecnica come il computo dei termini processuali ha assunto una rilevanza così cruciale per la tutela del diritto di difesa. La recente pronuncia della Cassazione civile Sez. [...]
Recent posts.
Gestione della crisi Eleven Finance: il piano dell'Avv. Sergio Scicchitano "Ho scelto il migliore". Titola così il documento allegato qui di seguito, che illustra il piano di ristrutturazione predisposto per Eleven Finance srl, società [...]
Con la sentenza n. 34809/2025, emessa in data 26.09.2025 e pubblicata in data 24.10.2025, la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato una questione giuridica di notevole rilevanza. Gli Ermellini hanno, infatti, [...]